PAUL AUSTER il viaggio di Anna Blume et alia
 |
| dipinto di Alice Nieri foto ©JSpaccini |
Premessa
Non è stato facile, questo libro (in italiano: Nel paese delle ultime cose). L'ho dovuto riprendere in mano tre volte, per entrarci dentro.Iniziavo, leggevo le prime righe e qualcosa in esso mi respingeva.
Complice forse la copertina della versione francese (il titolo originale è In the Country of Last Things), sentivo che mi attendeva qualcosa di forte, di ostico, qualcosa che richiedeva ben più dell'amorevole attenzione cui dedico alla lettura.
Frettolosamente, dicevo: Non mi prende, stavolta, Paul Auster .
Ma poi, a distanza di qualche mese mi imponevo di riaprire le pagine di questo romanzo: Non è possibile. Non può NON piacermi. Amo tutto, di Auster...
 |
| Hopper |
Ho preso una scorciatoia dell'intelletto. Ho deciso di leggerlo come se dovessi tradurlo in italiano. E il primo incanto s'è sciolto come un grappolo d'uva moscato in bocca: le parole. Curate, precise, per nulla arzigogolate. Parole che non lasciavano scelta: prendere o lasciare. Auster non giocava con la metaletteratura com'era solito fare; non faceva il verso compiaciuto a se stesso dell'estrema sua intellettualità.
Questa Anna Blume, a dire il vero, non è per nulla simpatica. E la quasi totale assenza di dialoghi (il romanzo è narrato sotto forma di diario su un improvvisato quadernetto destinato a un suo ex amore ancora nel suo cuore - a noi lettori -) all'inizio infastidisce.
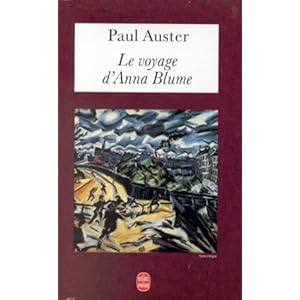 Ma è nella crudezza del taglio semantico, nella
totale riluttanza a commuoverci che sta la carta vincente di questo
anomalo romanzo. All'inizio ci si chiede se non ci si debba attendere la
rivelazione di un Paese nascosto, qualcosa da scrostare dietro la
storiella del Paese senza nome in cui vive prigioniera Anna: sarà la
rappresentazione dell'URSS staliniana? O forse un qualunque Stato ove
governi dittatoriali si avvicendano affamando i loro cittadini? Tutto è
surreale? Una fiaba amara? Fantapolitica? Esse est percipi, alla Berkeley? Nulla è esistito se svanisce?
Ma è nella crudezza del taglio semantico, nella
totale riluttanza a commuoverci che sta la carta vincente di questo
anomalo romanzo. All'inizio ci si chiede se non ci si debba attendere la
rivelazione di un Paese nascosto, qualcosa da scrostare dietro la
storiella del Paese senza nome in cui vive prigioniera Anna: sarà la
rappresentazione dell'URSS staliniana? O forse un qualunque Stato ove
governi dittatoriali si avvicendano affamando i loro cittadini? Tutto è
surreale? Una fiaba amara? Fantapolitica? Esse est percipi, alla Berkeley? Nulla è esistito se svanisce?Macché, macché. Non ha nessuna importanza tutto ciò.
Che questa storia sia nata da un evento reale o da un incubo austeriano, quel che conta è Altrove.
E' nell'essenza stessa dell'umano esistere. E delle relazioni terrene.
E' una sorta di ipotesi ragionata sull'homo hominis lupus: in un Paese in cui si uccide per una crosta di pane e che quando il pane non c'è più, si mangiano topi con ancora i peli addosso e quando anche i topi vengono meno si smembrano corpi umani che non sono ancora cadaveri, c'è ancora posto per la filosofia, l'amore, l'Idea?
 |
| foto prelevata dal blog hopersoiltreno.blogspot.com |
Se no, che cosa si diventa? L'abisso ha una fine o è incalcolabile?
E se, invece, a dispetto di ogni logica, c'è spazio per un sì, come avviene ciò - e soprattutto attraverso quale forza eversiva, tale da superare la insopprimibile prepotenza della fame e dell'abbrutimento, la sopraffazione prevaricatrice della sopravvivenza (nel romanzo ci sono anche le sette suicide, ma non anticipo troppo) -?
Il romanzo ha una trama forte, spiazzante, ma perfettamente coerente. Ad Anna si affiancheranno numerosi compagni di viaggio (la maggior parte di essi si perderà per strada): Isabella, Sam, Victoria, Boris, Willy, Bogat, Ferdinand (notate l'eterogeneità dei nomi. Attraverso di loro, Auster abbraccia lingue e Paesi a noi noti). E' un mondo in cui i libri sono buoni per riscaldare e vanno bene per il braciere, tanto vi fa freddo.
Ma nonostante tutto, sopravvivono solo coloro che coltivano una speranza: quella di andarsene, ma anche quella di sentire di non appartenere a nessun luogo.
 |
| Rouault I tre clowns |
Oppure, altrove: "Era come essere un confessore, diceva [Sam, n.d.r.], e poco a poco si è messo a misurare tutto il bene che si fa quando si permette alla gente di sfogarsi - quel salutare effetto di pronunciare le parole, di lasciarle uscire. Parole che raccontano quel che è successo a ciascuno di noi. [...] Farsi passare per un dottore gli aveva improvvisamente dato accesso ai pensieri intimi degli altri, e questi pensieri cominciavano ora a far parte di lui. Il suo mondo interiore è diventato più vasto [...]".
La speranza fa ripartire. Anche se tutto non è null'altro che illusione.
La fine è solo immaginaria, una destinazione che inventi per continuare ad andare avanti, ma arriva il momento in cui ti rendi conto che non ce la farai mai. Può darsi che tu sia costretto a fermarti, ma allora sarà perché hai poco tempo davanti a te. Ti fermi, ma questo non significa che sei arrivato fino in fondo.E il romanzo non finisce qui. Non con questa frase finale.




